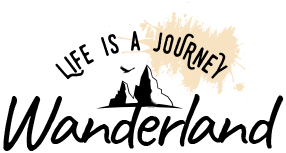30ª TAPPA: valdemarsvik
Ore 5.25
“In principio era il Verbo”, scrive Giovanni nel suo vangelo. Il logos, la vera prerogativa umana, quella che mi sveglia di colpo, pronunciata da un gruppo di turchi a pesca nell’unica mattina degli ultimi giorni in cui la stanchezza aveva finalmente vinto su tutto, permettendomi di dormire senza sobbalzi notturni. Sarà un segno. Chiudo la tenda senza fare colazione e seguo il mio daimon verso Nord. Prima di partire carico la cartina sul navigatore e mi accorgo che Stoccolma non è poi cosi lontana. Se m’impegno più degli altri giorni potrei raggiungerla in tre tappe, quattro al massimo.
Sono galvanizzato, mi massaggio le gambe e guardo l’orizzonte con la determinazione di un pentatleta.
Appena uscito dal centro della città mi trovo subito a costeggiare il mare in un’insenatura stretta, ma lunga una decina di kilometri.
Mi sembra di pedalare in riva ad un lago e non riesco a capire perché non ci sia un ponte che colleghi le due sponde. Le mie gambe ringraziano!
Il paesaggio è pressoché identico a quello dei giorni precedenti ma la morfologia del terreno cambia parecchio. Le salite sono più ripide e frequenti, anche per questo le mie gambe ringraziano. L’idea di raggiungere Stoccolma in tre tappe si allontana, insieme ad un doccia e ad un letto caldo e soffice. Nella vita c’è sempre qualcosa da finire, come il libro che è sul comodino da un mese o quella cosa che non hai mai aggiustato, o la tappa del giorno anche se sei stanco. Personalmente per abitudine rimando un sacco di cose che non dovrei e benché mi dia da fare quotidianamente in un milione di attività, ho sempre la sensazione che il tempo mi scivoli via dalle dita. Il mio viaggio, non questo per intenderci, è sempre stato senza destinazione, ho sempre fatto su e giù senza mai guardarmi troppo intorno e non credo che le cose in futuro cambieranno, benché meno oggi!
Inoltre il calcolo delle distanze è stato fatto senza tener conto di un sacco di complicazioni che mi porto appresso: un drone, attrezzature fotografiche, un Mac con hard disk a seguire, una moka, 2 kg di caffè della Genovese indispensabili per la mia salute mentale, una serie di calzini spaiati da cui non voglio separarmi e un armadio di indumenti estivi che spero possano essermi utili se decidessi di fare il ritorno in bicicletta puntando su Honolulu. Insomma, valige fatte con la cognizione di causa di un esploratore dei ghiacci.
Finalmente, dopo 25 kilometri arrivo al bivio che mi porterà verso nord. Mi volto e rivedo il punto di partenza sull’altra sponda dell’insenatura, ripenso al ponte che non c’è. Pace. Non è tardi forse riesco davvero a finire la tappa.
Mentre pedalo ripenso alle esperienze vissute nell’ultimo anno, a quel 24 febbraio a Odessa, al primo boato udito nel cuore della notte, seguito subito da un secondo più nitido e da un cielo che si è colorato di rosso vermiglio. Ai carri armati, ai morti lungo la strada, agli occhi persi nel vuoto di decine di donne in procinto di abbandonare le proprie case e i propri mariti. I miei ricordi si fondono con quelli di storie raccontate da altre donne che hanno vissuto uguali momenti di terrore e incertezza sul fronte bosniaco. La guerra rende lucidi, forse troppo, ma quando ne sei lontano ti confonde le idee. Non ci penso spesso, forse un meccanismo di autodifesa mi consente di reprimere i brutti pensieri. La solitudine può essere una grande maestra di vita, ma alcune volte, quando viene da dentro e riflette uno stato d’animo che non ci appartiene, evoca pensieri cupi, chiusi a chiave in cassetti sepolti nell’anima.
Mi fermo in un piccolo paesino sulla costa a fare alcune fotografie.
Il colore ocra delle case del villaggio mi distoglie dai pensieri che mi angosciano. Cerco di mettere a fuoco qualcosa e mi concentro sulla realtà. Per fortuna l’occhio è vigile e non riposa mai.
Il villaggio è piccolo, ma spesso nei luoghi piccoli si trova una vita grande.
Poche case di legno sono edificate sulla spiaggia e altrettante a ridosso della strada. Tutte danno sul piccolo porticciolo di pescatori costruito in un piccola insenatura nella baia di Bravinken.
Mi siedo, respiro, il luogo è idilliaco. Immagino una vita condotta in un posto del genere. Forse un po’ estremo come pensiero, fuori da qualsiasi rotta main stream, fuori dall’universo moderno, ma dentro un mondo che aspetta di essere plasmato, una realtà alternativa a quella costruita per tenerci in scacco. Una vita di protesta, ma senza un seguito. Questo rimane un pensiero senza voce, uno di quelli che non muove il corpo e non produce immagini per un’esperienza comune. Un’esperienza che si trasforma in una visione tortuosa che solo chi è dotato di una reale disperazione può toccare. Un desiderio di riconquista di sé, dove il passato e il futuro sono fermi sulla soglia del presente che è vivo e abita lo spazio.
Lungo la strada incontro una ragazza, in bicicletta anche lei, ha tutta l’aria di una turista, ma le sue valige sono scarne. Mi ferma per chiedermi un’indicazione e il suo accento non la tradisce. Stati Uniti. Si chiama Page, viene da New York ed è partita dalla Germania da sola per raggiungere Stoccolma con le valige completamente vuote. Facciamo un tratto di strada assieme e mi sembra di inseguire Bartali. Non voglio fare figure di merda, anche se non dovrebbe importami, mi sforzo di stare al passo facendo una fatica disumana. Sento tutto il peso dei miei bagagli sulle gambe già provate dai quasi 3000 km pedalati nell’ultimo mese. Ma devo essere sincero, inseguirla mi ha fatto raggiungere Stoccolma in tre giorni, diversamente non ci sarei riuscito.
Il giorno finisce com’è cominciato. Arrivo a destinazione nuovamente con il buio e con la luna che schiarisce la strada. Anche questa sera mi accampo nei pressi di un porto di una piccola città, e mi addormento con i turchi che pescano in riva al mare.